Don Claudio Burgio: «Al Beccaria la violenza è normalizzata. Baby Gang? Il capro espiatorio del disagio adolescenziale» – L’intervista
Oggi è il compleanno di Dino alla comunità Kayros, l’associazione creata da Don Claudio Burgio nel 2000 per dare un’alternativa al carcere ai minori in difficoltà. L’appuntamento è alle 20 per la pizza nel salone. Dino arriva con le buste della spesa e ad attenderlo c’è Daniel, che ha lasciato la comunità da qualche anno ma continua a frequentarla «per lavoro e amicizia». La sua storia è diventato un libro Ero un bullo, che Daniel porta in giro per le scuole con orgoglio. Alla pizza di Dino ci sarà anche lui. Qualche metro più in là in sala registrazioni c’è William Boy, che incide una sua canzone, e Andy che lavora al suo primo video musicale mentre un gruppetto partecipa a un laboratorio di video making. Tre ragazzi – pantaloni neri, cappuccio in testa e sigaretta – camminano frettolosamente verso le loro stanze. Sono arrivati da poco dal Carcere minorile Beccaria, dove don Claudio è cappellano. Qualcuno lascia intendere che il loro trasferimento possa essere legato alle violenze emerse nelle ultime settimane all’istituto. Se è così, don Claudio e i suoi collaboratori – da anni impegnati nella rinascita di questi giovani uomini – lo scopriranno nel migliore dei casi tra molto tempo. Perché, dice il Don, «la differenza più grande che noto in questa generazione di giovanissimi è che non parlano. Si fa molta più fatica oggi a tirare fuori il loro vissuto e le loro emozioni». A questo serve la musica sui cui Kayros ha investito molte risorse. Dalla comunità sono usciti alcuni dei rapper più famosi in circolazione: Baby Gang, Sacky, Simba La Rue. Asticelle di popolarità e qualità discografica molto difficili da raggiungere, anche se – come racconta Jacopo mentre ci fa ascoltare sul suo smartphone delle barre che sta componendo – «ognuno deve tirare fuori quello che ha dentro a modo suo, c’è chi ci riesce con la musica, chi con la scrittura o con un libro». Il suo amico Gabriel per esempio – l’unico che a Vimodrone sta scontando gli arresti domiciliari – lo fa con il pallone: «Il calcio è la mia vita», dice. Ai ragazzi della comunità, Don Claudio ha dedicato molti libri nel tentativo di raccontare le loro storie a una società che li etichetta in fretta come delinquenti. Lo fa anche con Non vi guardo perché rischio di fidarmi (Edizioni San Paolo) in cui Burgio, 55 anni, raccoglie «storie di caduta e di risurrezione». Sempre guidato da un principio: «Riuscire a guardare un ragazzo non solo per come si presenta oggi, ma per come può diventare».
Il motto della sua comunità è «non esistono ragazzi cattivi». Lo pensa ancora?
«I ragazzi di oggi non sono cattivi ma captivi cioè prigionieri, schiavi di un’ immagine, di un consenso sociale alimentato dai social che diventa preponderante nella loro vita. Rischiano di perdere la loro identità nella rincorsa di modelli appariscenti che rispondono a un’idea falsa di successo. Dobbiamo aiutarli a ritrovare la parte vera di sé. Non allontanandosi dal mondo dei social, ma aiutandoli a scorgere il senso delle loro azioni, delle loro scelte, anche dei loro sbagli».
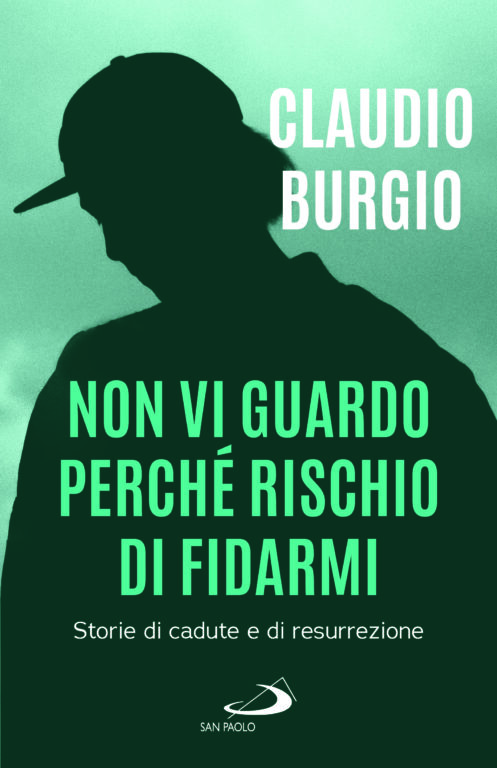
Scrive che la cosa che la preoccupa di più è che molti non hanno la consapevolezza della gravità dei reati che commettono.
«Purtroppo è così. Quando arrivano al Beccaria, spesso trovo dei ragazzini che non riescono a capire il disvalore dei loro gesti. Il nostro compito educativo è aiutarli a prendere coscienza gradualmente di tutto quello che hanno vissuto. Molti reati sono solo la punta dell’iceberg: il frutto di un disagio molto profondo. Per questo è importante andare a scoprire con loro la storia della loro famiglia, del loro quartiere – tutti i codici che hanno ricevuto e fatto propri – per poi aiutarli a sviluppare un percorso diverso. Quello che è importante è che non siano più solo ostaggi delle loro impulsività».
Quanto si riesce a fare dentro il carcere questo percorso che descrive?
«Un qualsiasi tipo di percorso in carcere di questi tempi è veramente proibitivo. Dire che il carcere è un luogo di rieducazione è una menzogna: è una scuola di crimine, un’istituzione totale che rischia di diventare totalitaria. La comunità deve essere tutt’altro. La regola dei cancelli sempre aperti – giorno e notte – che abbiamo qui a Kayros, per esempio, è la sfida della libertà: significa dire a un ragazzo che la scelta di restare è sua».
Quanti scappano?
«Non molti e quei pochi che lo fanno tornano sempre. Molti di loro hanno bisogno di fuggire per poi tornare con maggiore consapevolezza. Non dobbiamo pensare che una trasgressione sia la fine di tutto, a volte la trasgressione è quasi necessaria nel loro cammino».
La giustizia penale minorile in Italia ha costituito a lungo un modello europeo perché più orientata al recupero che alla pena. Lo è ancora?
«I fattori che ci hanno portato indietro sono essenzialmente due. Il primo è l’assimilazione dei tribunali per i minorenni ai tribunali ordinari. Una riforma, forse necessaria, che però rischia di far disperdere le competenze dei giudici minorili che erano molto specialistiche, necessarie per leggere le vicende dei ragazzi non solo nel segno del Codice penale ma partendo dalla loro storia personale. La giurisdizione minorile prevede una conoscenza della personalità dei minori. Prima i giudici onorari erano persone competenti anche dal punto di vista psicologico-educativo. Un valore enorme che ora rischia di diradarsi e disperdersi. E poi è arrivato il decreto cosiddetto Caivano, che inasprisce le pene, prevedendo il carcere per alcuni reati. I risultati sono stati immediati: mai il numero dei minorenni in carcere è stato così alto. Siamo passati da poco più di 400 di due mesi fa a oltre 550 detenuti. Questo decreto non va certamente a cogliere il problema, si limita a stigmatizzare le condotte e a criminalizzare i ragazzi. Crea un allarmismo sociale, legittimo, ma senza alcuna base scientifica: il numero dei reati non si è alzato in questi anni. Diciamolo una volta per tutte: non ci sono più ragazzi in carcere perché sono aumentati i reati. Ci sono solo misure più afflittive che non scongiurano nuovi atti di reato: certo non è un decreto a fare da deterrente».
I minorenni in carcere sono aumentati anche perché tanti sono stranieri senza una casa che arrivano da soli in Italia
«Anche vent’anni fa c’erano tanti ragazzi minori stranieri non accompagnati che entravano in carcere. Quello che è cambiato con la seconda ondata migratoria è lo sguardo dell’adulto. I ragazzi, come i reati, sono sempre quelli. Oggi c’è un maggiore allarmismo e una grande difficoltà a recepire lo straniero come parte della nostra cultura. Lo viviamo ancora come emergenza quando è un fenomeno irreversibile. Detto questo, è vero che le carceri minorili, del Nord soprattutto, sono strapiene di minori stranieri non accompagnati che entrano per piccoli reati e rischiano di stare mesi incarcerati, perché non si trovano le comunità e non ci sono possibilità alternative al carcere. Questo provoca in loro una grande ansia, una grande frustrazione che poi degenera anche in atti violenti».
Rispetto ai casi di abusi e maltrattamenti al carcere Beccaria, ha detto in diverse interviste che nessuno delle vittime si è confidato con lei. Non ha avuto percezione di quello che le accadeva intorno?
«Il Beccaria da molto tempo vive momenti di grande difficoltà. La mancanza di un direttore stabile, di un organico completo, di educatori. Da anni si segnalava una difficoltà, culminata con l’evasione dei sette ragazzi nel Natale 2022. Il clima negli anni è peggiorato parecchio: i ragazzi sono molto aggressivi e violenti nel modo di rispondere. Tanti segni sul volto, alcune ferite profonde le ho sempre attribuite alle risse tra detenuti, che in carcere sono quotidiane. Anche perché, a domanda precisa, i ragazzi non hanno mai risposto in maniera chiara e poi venivano immediatamente trasferiti».
Quindi lei ha provato a fare delle domande?
«Sì, anche perché in un paio di casi i segni erano molto evidenti sul volto. Ma la risposta era sempre: sono caduto, abbiamo litigato. Mai un accenno esplicito a violenze di questo genere, per cui anche per noi è stato impossibile immaginare una situazione così. I ragazzi che incontriamo sono talmente assuefatti al male, che la violenza è quasi normalizzata. Qualcuno dice “in fondo ce la meritavamo, siamo in carcere”. Ecco, questo è un discorso che mi fa rabbrividire ma dice anche che cos’è un carcere minorile: un luogo di punizione».
Parliamo di Baby Gang, finito di nuovo in carcere perché i suoi collaboratori hanno postato sui social delle immagini, un gesto che i giudici hanno interpretato come violazione dei domiciliari.
«Basterebbe ascoltare le sue canzoni per capire tante cose. Le violenze nel mondo delle carceri italiane, Beccaria compreso, erano già nei suoi testi ma non abbiamo creduto che potesse dire il vero. È molto facile ostracizzare le sue canzoni nell’immaginario collettivo perché fanno paura. Ma questo ragazzo – come altri che abbiamo avuto in comunità – descrive esperienze vissute e reali. Sono impopolari certo, perché ci fanno sprofondare nell’inquietudine. Io credo che Zaccaria abbia sempre riconosciuto i suoi reati e pagato per essi. Ma quando lo si accusa di cose non vere, lui reagisce e lo fa a modo suo, con modalità fortemente oppositorie. Vedo un accanimento nei suoi confronti».
Come se lo spiega?
«È diventato il capro espiatorio del disagio adolescenziale».
Il terrore è quello che sia un modello negativo per bambini e adolescenti.
«Le rispondo come mi ha risposto Zaccaria una volta: “Io sono cresciuto da solo ma i ragazzi che ascoltano le mie canzoni hanno i genitori e uno stuolo di educatori e insegnanti a guidarli”. Ovvero persone che possano accompagnarli nello sviluppo di un pensiero critico. Relazionarsi con un personaggio come Baby Gang può essere un’occasione per educarli, perché non si bevano tutto quello che vedono sui social. Le sue canzoni sono una provocazione: raccontano, come ha sempre fatto il rap, un pezzo di realtà che molti non vogliono conoscere: l’inguardabile, l’inascoltabile. Ma la sua storia è reale e riguarda molti, per questo dobbiamo avere il coraggio di ascoltarla».
Lei ha detto: Non è che la realtà fa schifo perché c’è Baby Gang ma c’è Baby Gang perché la realtà fa schifo.
«Baby gang c’è perché non c’è stato lo Stato. Certi luoghi e periferie sono pieni di bambini che vivono nel degrado più assoluto, in situazioni impensabili fino a pochi anni. E accade in quartieri a 20 minuti dal centro di Milano, come San Siro dove convivono il lusso e il degrado. Io non ho mai visto seri progetti sociali da parte di nessuna amministrazione cittadina. Ci sono situazioni di marginalità che non sono mai state affrontate e a chi mi dice non siamo le banlieu parigine, rispondo solo: speriamo di non diventarlo».
Riprese e montaggio video: Vincenzo Monaco
Leggi anche:
- La Statale di Milano prima in Italia per detenuti iscritti. Il coordinatore: «Classi miste, gratuità e tutor per motivarli» – L’intervista
- La lettera di Baby Gang chiuso in cella: «A spaventarmi non è il carcere, ma l’idea di essere marchiato a vita»
- L’artista più ascoltato in Italia è (di nuovo) in carcere: Baby Gang primo in classifica dalle sbarre di Busto Arsizio
- Caos al Beccaria prima dell’incendio, la rivolta notturna con l’arrivo del nuovo direttore: «Una devastazione completa»
