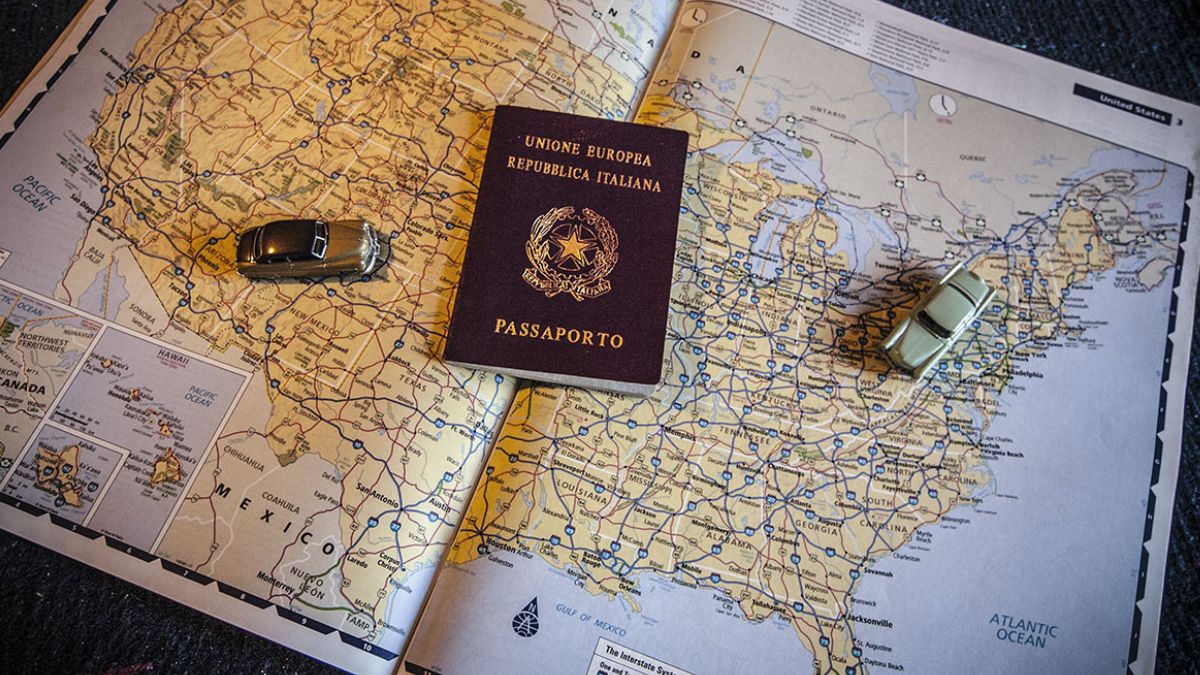Paul, fuggito dalle torture di Boko Haram in Nigeria per finire in carcere nell’America di Donald Trump
«Sono venuto in America perché è la terra della libertà. Non credevo di poter provare qui il terrore che ho vissuto in Nigeria». Paul Dama, 47 anni, faceva il giornalista quando è fuggito dal suo Paese dopo essere stato sequestrato e torturato dai terroristi di Boko Haram. Nel 2019 ha raggiunto negli Stati Uniti la sorella Cecelia, pluripremiata chef del ristorante africano Suya Joint, punto di riferimento della scena culinaria del New England. In quel ristorante Paul è diventato un manager molto amato da clienti e colleghi. Eppure, una domenica di giugno 2025, la sua vita è tornata indietro alla pagina più buia: «Stavo guidando verso la chiesa e all’improvviso sono stato “attaccato” da cinque auto diverse, mi hanno bloccato in tutte le direzioni. Ero terrorizzato perché non capivo cosa stesse succedendo». Quella mattina Paul è stato arrestato da una decina di uomini incappucciati appartenenti all’ICE, l’agenzia federale incaricata di far rispettare le leggi sull’immigrazione. «Mi hanno detto di mettere le mani dietro la schiena. L’ho fatto. Poi mi hanno ammanettato e portato via», racconta a Open, finalmente al sicuro sul divano del suo ristorante. «È stato spaventoso. Mi ha riportato alla mente quello che mi era successo in Nigeria: il rapimento, le violenze, il terrore di non sapere cosa mi sarebbe accaduto».

L’arresto e la detenzione in carcere
Dopo la cattura, Dama è stato trasferito in una struttura dell’ICE in Massachusetts con l’accusa di non avere lo status legale per restare negli Stati Uniti. In realtà la sua richiesta di asilo — presentata alle autorità appena arrivato — risultava ancora “pendente”: a distanza di sei anni non era stata processata dal tribunale per l’immigrazione. «Mi hanno concesso subito l’autorizzazione per lavorare e il numero di previdenza sociale: entrambi erano ancora validi al momento dell’arresto. Tutti i miei documenti erano validi. Ho sempre pagato le tasse in questi anni». Forte di queste certezze, Paul ha chiesto di uscire su cauzione, ma la richiesta è stata respinta a causa di due condanne per guida in stato di ebbrezza.
L’ex giornalista è stato quindi trasferito in carcere, dove ha trascorso cento giorni, fino a quando un giudice gli ha riconosciuto lo status di rifugiato atteso per sei anni. «In quei lunghissimi giorni ho pensato molto ai pericoli che avrei affrontato se fossi tornato nel mio Paese: probabilmente avrei perso la vita, perché Boko Haram non dimentica. Pensare a questo, e sentire il sostegno che ho ricevuto da clienti e amici, mi ha incoraggiato ad andare avanti». In cella Dama ha ascoltato molte storie: «Molti avevano casi simili al mio, con richieste di asilo in sospeso. Alcuni, senza pendenze penali, sono usciti pagando la cauzione. Ho conosciuto persone incarcerate per una multa per eccesso di velocità o altre infrazioni minori: non certo per condotte criminali come si sente in tv».
Paul sa di essere stato fortunato: «Molti hanno firmato per lasciare volontariamente il Paese perché non potevano permettersi un avvocato o non avevano il sostegno economico e morale necessario per restare rinchiusi nell’incertezza». Nonostante tutto, non prova risentimento verso il Paese che l’ha detenuto per cento giorni: «L’amministrazione Trump è arrivata con una politica chiara: hanno detto fin dall’inizio che avrebbero deportato gli irregolari. Certo, hanno anche promesso di stanare “i peggiori dei peggiori”, e invece vediamo molte persone prese a caso». I timori di Paul oggi si riflettono anche sull’attività economica: «Il nostro ristorante, frequentato da tantissimi immigrati, sta registrando un calo. Molti preferiscono ordinare online piuttosto che sedersi al tavolo senza sapere se, uscendo di casa o dal locale, potrebbero essere arrestati», racconta. Eppure, quello che è successo ha non cambiato la sua percezione dell’America: «Continuo a credere che il sistema giudiziario sia ancora forte, indipendentemente da ciò che sta accadendo là fuori. E ringrazio il governo per avermi concesso l’asilo».

La caccia agli immigrati
La storia di Paul Dama è una delle tante che raccontano la nuova America di Donald Trump. Da quando il presidente ha annunciato la stretta migratoria, le strade delle città principali sono presidiate da migliaia di agenti dell’ICE in cerca di “criminal aliens” da arrestare e rimpatriare. Secondo il Dipartimento della Sicurezza Interna, dall’inizio della seconda amministrazione Trump più di 500.000 persone sono state deportate nei Paesi d’origine e 1.600 hanno lasciato volontariamente gli Stati Uniti. Non esistono dati governativi aggiornati sulle detenzioni, ma, secondo il centro di ricerca TRAC della Syracuse University, sono circa 60.000 gli immigrati in custodia dell’ICE: di questi quasi il 70% non ha condanne penali a carico.
Jessica Vaughan, direttrice del Center for Immigration Studies — considerata tra le menti della nuova strategia migratoria di Trump — spiega a Open la condotta dell’agenzia federale che, grazie al presidente americano, ha ricevuto un importante rafforzamento finanziario e operativo: «In passato gli agenti ignoravano chi non era il bersaglio principale. Oggi la politica è cambiata: se scovano qualcuno che si trova illegalmente nel Paese, anche se non è l’obiettivo dell’operazione, devono comunque arrestarlo». Secondo Vaughan, questo vale in particolare nelle cosiddette “città santuario”, che limitano per legge la cooperazione con le autorità federali sull’immigrazione. Negli Stati Uniti se ne contano almeno 300, tra cui Boston, Chicago, New York e San Francisco. «Metà della popolazione che vive illegalmente negli Stati Uniti risiede in questi luoghi, dove la polizia locale non può collaborare con l’ICE, e questo complica le cose».
Jessica Vaughan, l’esperta dietro la stretta anti-migranti americana
Nei primi dieci mesi dell’amministrazione Trump moltissime persone sono state fermate in luoghi pubblici e privati, con operazioni spesso spettacolari e violente. Su TikTok e Instagram circolano video da tutto il Paese che mostrano agenti mascherati, taser, gas urticanti, manganelli e droni usati per catturare persone in strada. Per Vaughan, una parte della responsabilità ricade proprio sulla scarsa collaborazione delle polizie locali: «Negli Stati che non collaborano, l’ICE è costretta a operare sul campo: cercare le persone nei quartieri, arrestarle nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nei tribunali o perfino per strada. Non amano lavorare così, ma sono costretti a farlo».
Lo scontro con le “città santuario”
Il Massachusetts, governato dalla democratica Maura Healey, è considerato tra gli Stati più ostili alle politiche federali sull’immigrazione. Qui, solo da giugno a settembre, ci sono stati 1.400 arresti condotti dall’ICE, più della metà ha riguardato persone senza precedenti o accuse penali. A Cambridge, sede dell’università di Harvard, il Consiglio comunale ha recentemente rafforzato la Welcoming Community Ordinance, che, tra le altre cose, invita i cittadini a non collaborare con i federali, a segnalare alla polizia locale la presenza di agenti e fornisce assistenza legale e abitativa ai rifugiati. La vicina Boston — dove la sindaca democratica Michelle Wu, quarantenne figlia di immigrati taiwanesi, è stata appena rieletta — è al centro di una causa con il Dipartimento di Giustizia per via del Boston Trust Act, un’ordinanza che proibisce alla polizia di chiedere lo status migratorio di una persona o di trattenerla su richiesta dell’ICE senza un mandato o motivazioni penali. L’obiettivo, sancito dall’ordinanza (approvata nel 2014 e rafforzata nel 2019), è evitare che le persone senza documenti abbiano paura di denunciare reati o di rivolgersi ai servizi pubblici. L’amministrazione Trump respinge questa impostazione: «Boston e il suo sindaco — ha dichiarato la procuratrice generale Pam Bondi — sono tra i peggiori trasgressori di questo sistema di protezione in America: le loro politiche indeboliscono l’applicazione della legge e proteggono gli immigrati clandestini dalla giustizia».
Il governo federale sostiene che il Trust Act violi la “Supremacy Clause” della Costituzione, secondo cui la legge federale prevale su quella statale o locale. Una questione così spinosa da far emergere dubbi anche negli ambienti più conservatori del diritto costituzionale. «La nostra Costituzione non consente al governo federale di impartire ordini agli Stati», spiega a Open Josh Blackman, docente e giurista, tra gli autori del Project 2025 della Heritage Foundation. «Il presidente non può ordinare alla polizia locale di arrestare gli immigrati clandestini». Tuttavia, precisa Blackman, neppure gli Stati possono interferire con l’applicazione delle leggi federali: «La polizia statale, ad esempio, non può circondare un edificio federale per impedire l’ingresso o l’uscita delle persone. Gli Stati possono cooperare con il governo federale, ma hanno anche il diritto di non farlo». Nel frattempo, mentre al Congresso è fermo un disegno di legge che smonterebbe l’architettura delle città-rifugio (tagliando i fondi a chi limita la cooperazione con le autorità federali), oggi sono i tribunali a respingere o avallare le politiche di Trump.
L’attivismo delle comunità
Il risultato è un clima crescente di incertezza tra le comunità di immigrati. «Le famiglie sono spaventate: alcuni non mandano i figli a scuola, altri si nascondono o preferiscono lasciare spontaneamente l’America», conferma a Open Jillian Philipps, responsabile dell’Office of New Americans di Worcester, in Massachusetts, e coordinatrice locale di Luce, una rete di volontari nata per aiutare i migranti senza documenti. Ogni giorno Luce riceve circa cento telefonate che segnalano la presenza di agenti mascherati nelle città. I volontari valutano le segnalazioni, decidono dove inviare i volontari per documentare gli arresti ed avvisano la comunità. «Abbiamo rafforzato la presenza nelle scuole — continua Philipps — e le partnership con associazioni locali che si occupano di assistenza materiale: fondi, tracciamento dei detenuti, biglietti per rimpatri volontari, collegamento con legali». Philipps lavora da anni con “i nuovi americani”, ma il suo sguardo è cambiato a maggio, quando ha visto agenti federali inseguire una donna con un neonato in braccio: «Vedere bambini strappati alle madri sul ciglio della strada è stato per me un punto di non ritorno», afferma con gli occhi lucidi.
Jillian Philipps, l’altra America che difende i migranti
Decine di festival e iniziative comunitarie sono state cancellate per paura di attirare gli agenti, mentre le scuole segnalano assenze crescenti tra gli studenti figli di immigrati. Anche le chiese sono sotto pressione. A East Boston, Holy Redeemer, una parrocchia cattolica che serve una comunità di circa 3.000 latinoamericani, ha sospeso la distribuzione gratuita di cibo dopo diverse retate. A pochi isolati di distanza c’è la chiesa protestante del reverendo Don Nanstad, diventata un punto di riferimento per rifugiati: «Le persone bussano ancora alla nostra porta sul retro: una madre con un bambino, un uomo che chiede di caricare il telefono per chiamare un cugino. Non possiamo risolvere la questione dell’immigrazione; possiamo solo continuare ad aprire una porta», spiega il pastore a Open.
I racconti che si alternano in questa piccola chiesa — con una grande cucina in acciaio e disegni alle pareti — hanno in comune la fine di un sogno: «Qualche mese fa — racconta Rafaela Radcke, collaboratrice della chiesa — è arrivata una madre single con un figlio adolescente in cerca di rifugio. L’ICE la stava cercando. Per quanto avremmo voluto dire sì, non potevamo: era troppo rischioso. Nascondere un minore comporta enormi rischi legali». I religiosi non si sono tirati indietro: hanno trovato un alloggio alternativo e coperto la quota mancante per l’affitto. Tra le persone che hanno bussato alla loro porta c’è anche una donna marocchina, in attesa della green card: «Aveva un dolore fortissimo a un dente e non voleva andare in ospedale. Abbiamo trovato un dentista disposto a curarla in sicurezza». C’è una madre latino-americana, che ha chiesto preghiere e aiuto per il figlio, arrestato in Arizona mentre era in vacanza con la moglie americana e rilasciato solo dopo il pagamento della cauzione.
«Siamo arrivati a raccogliere fino a 30.000 dollari per aiutare chi è in difficoltà», racconta il reverendo Nanstad. Quei fondi non servono solo agli aiuti materiali. «Stiamo cercando di avviare un percorso di formazione sulle leggi dell’immigrazione e un gruppo di sostegno con tutto ciò che serve: consulenti, traduttori, avvocati». L’attivismo della sua chiesa — insieme a quello di molti gruppi e organizzazioni — è parte della storia di East Boston: «Qui l’organizzazione comunitaria ha radici profonde — dal movimento italoamericano contro l’espansione dell’aeroporto negli anni ’50 e ’60 alle reti latinoamericane di oggi. A pochi metri da noi viveva Gene Sharp, il padre della non violenza che ha ispirato migliaia di giovani nel mondo». Il reverendo sa che la sua chiesa può essere un bersaglio, ma non ha paura: «Ho sempre detto che siamo la “chiesa di Janis Joplin”, perché la vera libertà è non avere più niente da perdere».

Riprese video: Serena Danna
Editing e montaggio video: Vincenzo Monaco