Lecanemab, il farmaco che rallenta l’Alzheimer. Come funziona e perché si parla ancora di risultati parziali
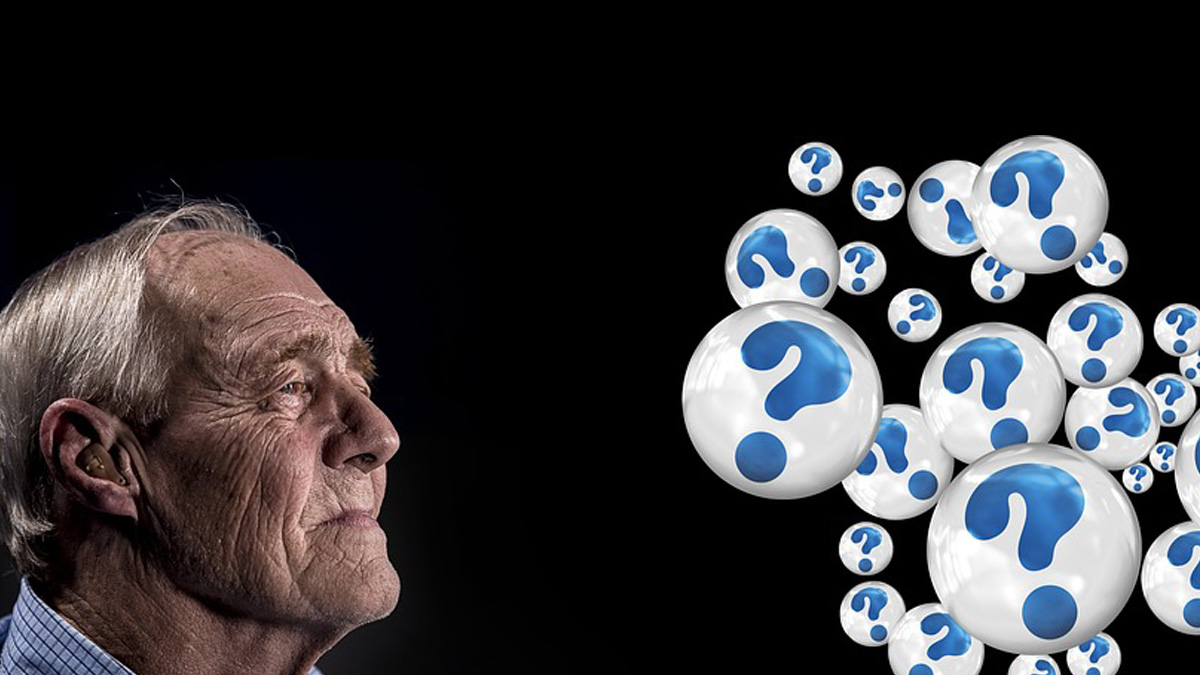
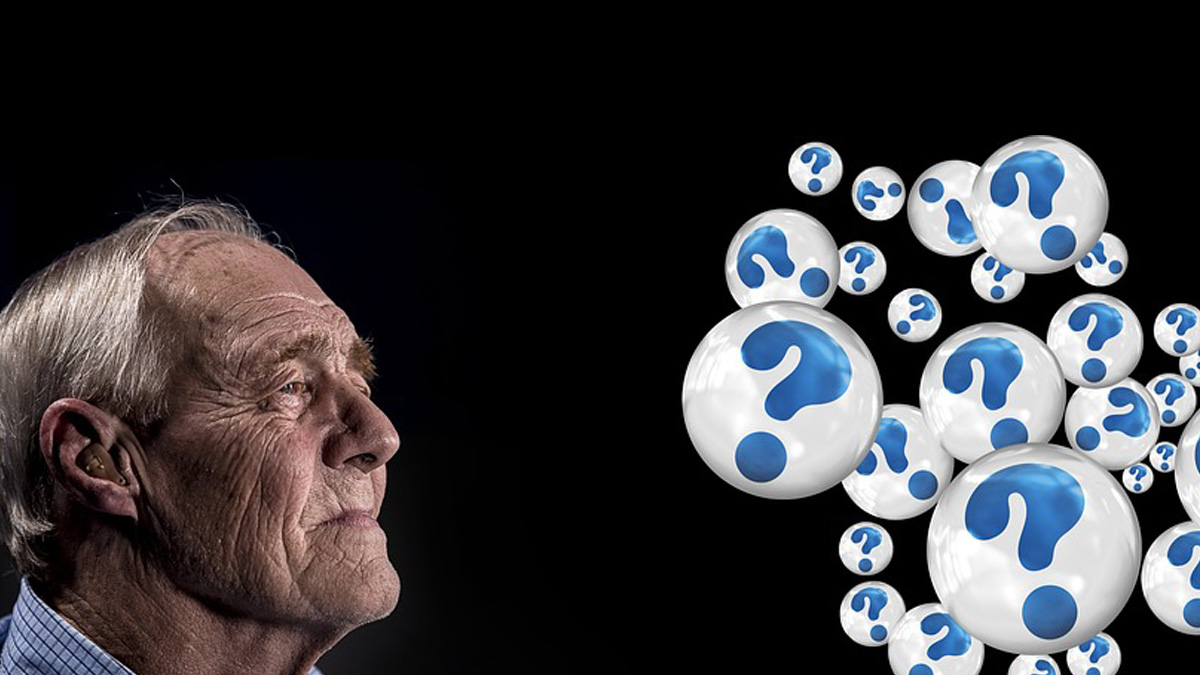
Secondo i risultati di un trial clinico apparso sul New England Journal of Medicine il 29 novembre, che ha coinvolto 1795 volontari, ci troviamo di fronte a una potenziale svolta nella ricerca sul morbo di Alzheimer. Parliamo dell’anticorpo monoclonale lecanemab, il quale se assunto nelle prime fasi della malattia promette di rallentarne il decorso. Parallelamente stiamo diventando sempre più bravi nella tempestività della diagnosi. Lecanemab agisce sulla Betamiloide, una proteina che accumulandosi nel cervello si associa a questa malattia neurodegenerativa. Il processo comincia 20 anni prima che vengano rilevati i primi sintomi. Il farmaco comunica col sistema immunitario, il quale prende così di mira la Betamiloide, impedendogli di aggregarsi tra i neuroni formando le caratteristiche placche dell’Alzheimer. Al momento i farmaci lavorano sui sintomi, senza intaccare il decorso. Il dottor Leonardo Biscetti, medico specializzato in neurologia a Perugia, in servizio presso l’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura dell’Anziano di Ancona, spiega a Open lo stato della ricerca sul trattamento dell’Alzheimer.
I principali bersagli dei farmaci
La ricerca – finanziata dalle case farmaceutiche Eisai e Biogen -, giunta alla terza fase di sperimentazione clinica, è uno studio multicentrico in doppio cieco. I pazienti tra 50 e 90 anni dovevano ricevere in maniera casuale il farmaco o un placebo. L’endpoint primario era quello di riuscire a ottenere una variazione significativa nella sintomatologia dopo 18 mesi di trattamento. Alla fine dello studio è stato riscontrato un rallentato di un quarto del tempo nel decorso della malattia. Non si tratta però dell’unico farmaco promettente; nel giugno 2021 si parlava di un altro anticorpo monoclonale: aducanumab. «Per maggiori approfondimenti trovate una mia analisi per Tpi su quel farmaco, imparentato con il monoclonale lecanemab. Entrambi agiscono contro la beta-amiloide – spiega Biscetti -, il primo era stato testato su due trial di terza fase (circa 1300 pazienti l’uno) dando risultati opposti (uno positivo e uno negativo, ma in quest’ultimo pareva intravedersi un vantaggio per le dosi più alte). Bisogna aspettare i risultati definitivi dei prossimi studi».
L’intero processo implica anche l’accumulo di proteine Tau, causando la morte dei neuroni e alterazioni biochimiche del cervello, portando a un progressivo peggioramento della memoria, fino ad arrivare alla perdita di diverse altre funzioni cognitive. «Si parla di Alzheimer quando il paziente presenta placche formate dalla proteina Betamiloide, che stanno fuori da neuroni e grovigli neurofibrillari formati dalla proteina Tau iperfosforilata. Sicuramente queste due proteine sono importanti nella patogenesi della malattia, ma non è chiaro il contributo di ciascuna di esse. Poi sicuramente giocano un ruolo altri fattori, ad esempio la neuroinfiammazione».
Il bilancio tra efficacia ed eventi avversi
Ora il problema è quello di valutare il bilancio tra benefici e potenziali eventi avversi, come si nota già leggendo le conclusioni del paper. Se approvata la distribuzione, il lecanemab potrebbe migliorare le condizioni di oltre 55 milioni di persone nel mondo, anche se al momento non abbiamo modo di fermare il decorso della malattia.
Lecanemab ha ridotto i marcatori di amiloide nella malattia di Alzheimer precoce e ha provocato un declino moderatamente inferiore delle misure cognitive e funzionali rispetto al placebo a 18 mesi – spiegano i ricercatori -, ma è stato associato a eventi avversi. Sono necessari studi più lunghi per determinare l’efficacia e la sicurezza di lecanemab nella malattia di Alzheimer in fase iniziale.
Ci sono dei limiti nei risultati del trial che stanno ispirando un certo dibattito. Per esempio, i ricercatori hanno valutato il declino della malattia sulla base dei sintomi con una scala a punti da 0 a 18. Il miglioramento per chi ha assunto il farmaco è stato riscontrato in un incremento pari a 0,45. Tanto che alcuni esperti hanno parlato di effetti modesti, anche se il farmaco fornirebbe comunque un appoggio.
Ma il processo di approvazione del lecanemab dovrà passare anche attraverso la valutazione dei presunti rischi correlati all’assunzione. «Gli effetti collaterali per questi farmaci sono modesti – continua il medico -, solo in casi molto rari si sono viste emorragie cerebrali, ma dagli studi di fase 3 non emerge un grosso alert di sicurezza. Ci sono invece ancora dubbi di efficacia. Tutti i monoclonali utilizzati prima hanno fallito. Aducanumab ha dato risultati controversi. Lecanemab sembra dare un vantaggio nel controllo di follow-up. Parliamo di due farmaci promettenti, ma è troppo presto per dire se funzionano. Su lecanemab i risultati sono parziali: il dato è buono ma il periodo di osservazione è troppo breve. Sicuramente entrambi i monoclonali portano a una riduzione della Betamiloide cerebrale. Quanto questo si associa a un vantaggio clinico è ancora in fase di studio».
La necessità di fare diagnosi precoci
Occorre anche contestualizzare la finestra di tempo normalmente a disposizione di un malato di Alzheimer prima di non essere più autonomo, ch’è mediamente di circa sei/sette anni. I miglioramenti osservati nello studio – che riducono i tempi di deterioramento a un quarto -, rappresenterebbero quindi 19 mesi in più di vita indipendente. Va ricordato comunque, che questi risultati valgono solo per chi viene diagnosticato precocemente. «Da diversi anni nei centri di riferimento, come il mio – continua Biscetti -, si fa la diagnosi attraverso due bio-marcatori, i quali si prelevano dal liquido cefalorachidiano. Si misurano quindi i livelli di Betamiloide e Tau. La prima è tendenzialmente bassa nei pazienti con Alzheimer, perché probabilmente rimane intrappolata nelle placche; la seconda invece la trovi alta perché sta nei neuroni, che quando muoiono la rilasciano nel liquido. Questo genere di analisi permette di diagnosticare la malattia anche in un soggetto ancora asintomatico».
Se non fosse che è necessaria ogni volta una puntura lombare. «Cosa che fai quando il paziente non è più asintomatico e si trova nella seconda fase, in cui comincia a manifestare i primi sintomi di declino neurocognitivo lieve a cui seguirà la terza fase della malattia, quella del declino neurocognitivo maggiore (un tempo nota come “demenza”), dove il paziente non è più autonomo». Quindi attenzione ai facili entusiasmi. «Serve cautela – conclude Biscetti -, aspettiamo i dati finali e i pronunciamenti delle agenzie del farmaco. Nella migliore delle ipotesi il farmaco rallenta il declino cognitivo. Ma né la blocca né tanto meno lo guarisce. Tuttavia dopo tanti fallimenti questi risultati ci lasciano un po’ di speranza e suggeriscono un cauto ottimismo».
Foto di copertina: geralt | immagine di repertorio.
Leggi anche:
- Il video del reparto Covid «vuoto» del San Martino di Genova: dedicato alla somministrazione dei monoclonali
- Bebtelovimab: il nuovo anticorpo monoclonale che funziona contro Omicron autorizzato dagli Usa
- Long Covid, il sintomo della nebbia cerebrale dopo la guarigione: «Simile a quella dell’Alzheimer» – Lo studio
- Test «selvaggi» sui malati di alzheimer e parkinson in Francia
- Camilleri e quell’aneddoto su Montalbano: «La fine? L’ho scritta 13 anni fa per paura dell’Alzheimer»
- «Sea Hero Quest»: un videogame per diagnosticare l’Alzheimer
- Alzheimer: nuovo test del sangue per scovare il morbo in tempo
