«Maggiore spazio all’esterno, abbattere ciò che non funziona più. Ecco come sarà la scuola del futuro» – L’intervista


La carriera dell’archistar Alfonso Femia è imperniata sui progetti di scuole, università e centri di ricerca. Ed è proprio dai luoghi dell’educazione, dove le nuove generazioni crescono e si formano, che bisogna ripartire. «È indiscutibile che la nostra categoria si trovi in sofferenza – afferma Femia, osservando la situazione dei colleghi fermi a causa dei cantieri bloccati per l’emergenza Coronavirus -. Ci sono attività legate all’architettura che si possono svolgere in remoto, ma le difficoltà economiche sono tante. Gli architetti, tuttavia, dovrebbero sfruttare questo periodo storico per ragionare su un nuovo inizio».
Femia è molto legato all’elemento dell’acqua, anche per le sue origini genovesi. Da anni lavora cercando di trasporre nell’architettura la centralità del Mediterraneo e del suo clima, che permette agli edifici di dialogare con gli spazi esterni. La necessità di un «tempo lento» da vivere in parallelo alla velocità del mondo contemporaneo è uno degli intenti dei progetti di Femia.

Architetto, cosa vede guardando alla ripartenza?
«In queste settimane, paradossalmente, chi parla di sicurezza degli ambienti si sta concentrando su uffici e case. Sono due tipologie di luoghi che hanno meno urgenze, semplicemente perché gli uffici, già prima di questa crisi, hanno subito delle buone rivoluzioni in termini di spazi e vivibilità. Per le abitazioni, invece, il discorso si fa meno emergenziale, dato che è difficile immaginare una modifica veloce del modo di abitare, perché le costruzioni già esistenti non consentono grandi cambiamenti nella gestione degli spazi».
Allora da dove bisogna ricominciare?
«Dagli spazi collettivi. Il coronavirus ha portato un confinamento delle persone, privandoci di quegli spazi. L’unico modo che la nostra società ha avuto per non disgregarsi è stata la rete. In realtà, se avessimo avuto degli spazi più ampi, più generosi, più attrezzati, avremmo potuto gestire diversamente il lockdown. Oltre che sensato, è un tema reale dal quale poter ripartire».
È un discorso applicabile anche alle grandi città con una densità abitativa più alta?
«Sì, bisogna avere il coraggio di occuparsi di quelle parti di città abbandonate che hanno modelli costruttivi antichi e ormai impossibili da recuperare. Bisogna intervenire sul corpo della città, immaginando che alcune cose possono essere demolite e altre recuperate. Se si analizza attentamente il corpo delle città italiane, si nota che il tasso tra costruito ed effettivamente utilizzato garantisce ampi spazi di manovra. Ricordiamoci anche che siamo un Paese dove non c’è incremento demografico e quindi non c’è il tema del sovraffollamento. Anzi, si sono liberati spazi che possono essere rigenerati».
Faccia un esempio.
«La città di Milano. Ci sono tantissimi spazi, anche centrali, che devono essere risviluppati con impostazioni differenti. Penso agli scali ferroviari, all’ex area macello, all’ex area industriale. Bisogna solo rovesciare il cannocchiale e guardare direttamente quelle che sono le occasioni dell’intero corpo cittadino. Ma vale anche per le piccole scale, molto presenti in Italia per natura del nostro territorio. Sarebbe un’azione responsabile, di buon senso, intervenire sull’esistente che, benché inutilizzato, è rimasto collegato con la parte attiva dei centri urbani».
Pensando alla sua categoria, quali sono stati gli errori commessi dagli architetti negli anni recenti?
«Il più grande errore è che in Italia, spesso, non si è intervenuti interrogando l’architettura per concepire le città. L’architettura è uno strumento utile per la società: deve essere interpretata così. Dall’altro lato, c’è stata un forte miopia da parte degli architetti nel non aver combattuto contro un modo di concepire gli spazi che si è asciugato, diventando meno generoso: ci si è piegati alla soddisfazione di regole tecnologiche. Ci si è trincerati dietro l’idea che la sostenibilità sia solo la pelle di una facciata o di dispositivi tecnologici. Non si è più, in maniera omogenea, progettato con una contiguità tra territorio, città e architettura. Veniamo da un periodo storico in cui i grandi progetti sono stati concepiti come isole, frammenti, senza un’azione osmotica con il contesto».

Quando si parla di riapertura di scuole e università bisogna pensare a una rivoluzione di quegli spazi che devono accoglierli?
«Assolutamente sì. La cosa particolare di questi due mesi è che si è parlato di case e uffici. Mai di giovani. Forse perché qualcuno dice che il coronavirus non danneggia particolarmente quella fascia d’età. Ma al di là degli effetti sanitari immediati, ha comunque creato una serie di conseguenze. Se non ci occupiamo degli spazi, dei luoghi delegati al tema dell’educazione, non riusciremo a fare in modo che le nuove generazioni si prendano cura delle città, del pianeta e, in qualche modo, di loro stesse».
Come se li immagina i luoghi della formazione?
«Questi spazi devono tornare a essere luoghi permeabili, aperti. L’approccio dev’essere quello di demolire gli edifici che non soddisfano certi requisiti e ricostruirli immaginando un collegamento costante tra le aule, gli spazi aperti, le aree verdi. La scuola deve diventare un paesaggio nel paesaggio. Sia nel cuore delle città che all’esterno. Il concetto è semplice: occorre immaginare le scuole come una sorta di piazze ambientali. Spesso si è costruito a isole separate dal resto, che sono l’opposto degli habitat, dell’ambiente visto e vissuto nella sua interezza».
Da dove iniziare?
«Bisogna creare un ambiente nell’edificio. Le strutture devono diventare più osmotiche, ancor di più nei luoghi della formazione. Gli spazi devono essere generosi: smettiamola di considerare le scuole come una categoria merceologica dove c’è una quantità di persone che deve entrare e uscire a certi orari. Abbiamo questa concezione delle scuole che sono un ripetersi di aule e corridoi. Non sono spazi adatti alla formazione di oggi: neghiamo quella parte di educazione che i giovani devono avere, cioè entrare nello spazio, rapportarsi con esso e vivere quegli spazi come momento di apprendimento».
Spazi più ampi garantirebbero anche il distanziamento sociale in situazioni di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo.

«Se oggi avessimo delle scuole che interagissero con il paesaggio, immaginate come sarebbe più facile gestire l’educazione durante l’emergenza sanitaria, con parte della didattica svolta all’esterno. L’edificio deve uscire dal suo perimetro e ancorarsi invece al luogo, al contesto circostante. Creare nuovi percorsi di formazione, perché il tempo, e noi siamo tempo, è un momento che va gestito in maniera totalmente differente rispetto a come si faceva una volta».
Cioè?
«La giornata dello studente ha ritmi e modalità diversi. Gli alunni vivono in costante connessione virtuale con il mondo, si interrogano su come la società sta cambiando. Quella connessione deve diventare anche reale, fisica. Se noi formiamo le nuove generazioni secondo la logica di un mondo preciso, limitato, recintato che non esiste più, facciamo un doppio errore. Perpetuiamo gli sbagli delle generazioni passate, che non davano importanza agli ambienti dei luoghi più o meno lontani, che non ci riguardavano, e non abituiamo i ragazzi ad avere un’interazione costante con il circostante».
Secondo lei perché non si è parlato, in senso stretto, di edilizia scolastica durante la crisi del coronavirus?
«Se ne parla poco perché gli istituti dove si fa formazione sono spazi pubblici e c’è bisogno di investimenti dello Stato. Negli ultimi 20 anni, e sappiamo che attualmente ci sono moltissime scuole non all’altezza, ci si è occupati del tema solo in seguito a tragedie come terremoti, per aggiornamento energetico o quando veniva scoperto dell’amianto. Piccoli interventi in un corpo che ha da decenni i sintomi di una malattia importante. Ci sarebbe bisogno di un progetto totale dell’edilizia scolastica in Italia. Quale occasione, se non il coronavirus, per ripensare spazi sicuri, areati, verdi e dove la distanza tra le persone è perennemente modificabile grazie all’assenza di un perimetro rigido?».
Perché tra il ripensare uno spazio e trovare i fondi per ricostruirlo, di mezzo ci sono scarsità di investimenti pubblici, codice degli appalti e un’impalcatura burocratica che limita la lungimiranza.
«Forse, ma un’azione di rinascimento, forte, è necessaria. I politici devono avere il coraggio di iniziare un grande piano per la demolizione degli edifici non più adatti alla formazione e investire risorse per farne di nuovi. Può diventare una grande occasione di progettualità per il futuro del Paese. E quando si parla di futuro, non si può non partire dai giovani».
Ci dia qualche elemento per costruire la scuola del domani.
«Portando un esempio concreto, immaginiamo di partire dagli ambienti scolastici dove si vive l’attesa. All’ingresso e all’uscita da scuola, genitori e ragazzi sostano in aree che non sono idonee. Lo spazio dell’attesa deve essere più ampio e bisogna pensare che intorno all’edificio ci sia un sistema di filtro verde, attrezzato. La stessa area deputata al passaggio diventa un ambiente vivibile e i flussi di persone che l’attraversano si fanno più gestibili, meno caotici. All’interno si devono implementare sistemi di corti, dove l’apertura e il verde non siano più solo luoghi di attraversamento, ma dove svolgere attività di formazione. Le scuole devono essere estroverse, non introverse. Il clima italiano, mediterraneo, ce lo permette. La sequenza di corridoi, scale e aule, che fa apparire le scuole come delle carceri, non è più possibile. Le ricette possono essere tante e semplici, l’importante è avere un progetto e il coraggio di guardare a nuove dimensioni collettive».
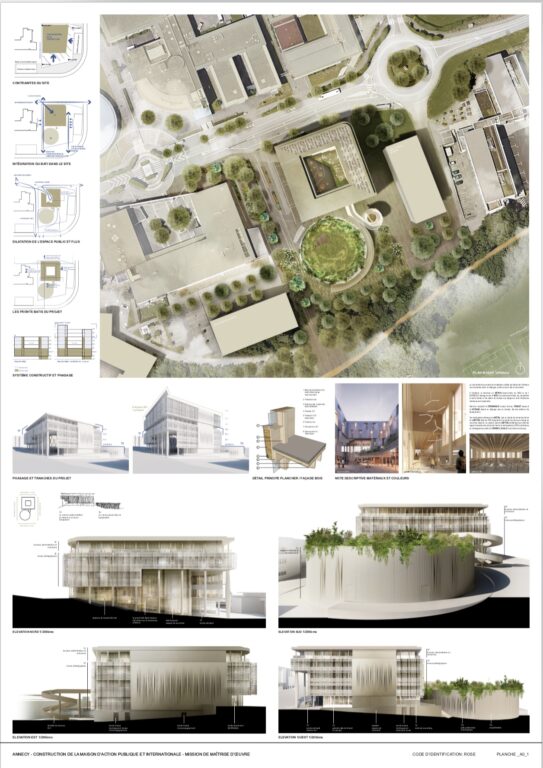
Sullo stesso tema:
- Il grattacielo più alto del mondo compie 10 anni, Boeri: «Il Burj Khalifa non è un esempio per il futuro» – L’intervista
- Girando per le strade deserte di New York si incontra solo chi una casa non ce l’ha – Il video racconto
- Non tutte le emergenze fanno lo stesso rumore: Rosa, Calogero, Lucia, parlano i nuovi poveri da Coronavirus
- Coronavirus, il caso Piemonte: perché diventerà la seconda regione più colpita di Italia
- Coronavirus. L’epidemia, il dolore, la morte. Dove si nasconde Dio? – Il video
- Coronavirus, il mese sacro del Ramadan tra lockdown e moschee chiuse
- Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Usa il numero dei morti supera i 46mila. Trump frena sulle riaperture in Georgia: è scontro con il governatore
- Coronavirus, la denuncia di un malato oncologico: «Io, lavoratore autonomo, non ho diritto ai 600 euro del Governo»
- Ansia, poco sonno e problemi nell’apprendimento. Il lockdown vissuto dagli studenti – Lo studio
- Napoli, sesso in cambio di esami: sospeso professore della Federico II
- Carlo Ratti: «Niente più uffici, lezioni online e laboratori: così cambierà l’università»
- «Tribù di studenti, lezioni online e innovative e investimenti. Così rispondiamo alla sfida delle università straniere» – L’intervista
- La Maturità col Coronavirus, diario di un presidente di commissione: i mille dubbi del fischio di inizio
